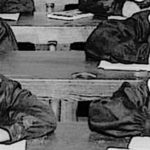
LA SCUOLA MEDIA ACCUSA. LA SCUOLA ELEMENTARE RISPONDE.

SENTIRE IL GRISOU
ἜΠΕΣΕ ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ”. CADDE COMBATTENDO…

Raramente un’epigrafe mi ha commosso tanto, devo dire. Non di una singola si tratta, ma di innumerevoli epigrafi che, con la stessa scritta, costellano piazze e giardini di tantissimi villaggi ciprioti.
Piccoli monumenti di marmo candido, coronati dal busto dell’eroe, in divisa o in abiti civili, lo sguardo capace di far parlare la pietra, comunicando fierezza e sollecitando riflessione. Sotto, il nome, l’età e quelle poche parole antiche come antica è l’isola, a ricordare il sacrificio di una vita donata alla patria.
È proprio il suono antico delle parole a commuovermi: quei due verbi, accostati da secoli, sempre loro, a rendere onore a una vita spezzata dalla guerra. Sempre loro: uno, cadde, all’indicativo aoristo che, come e meglio del nostro passato remoto, indica un punto preciso della storia, istantaneo, unico e irripetibile, come è la morte; l’altro, al participio presente che, come il nostro, indica un’azione, una postura fisica e interiore propria del soggetto, prolungata nel tempo, come se combattere fosse il destino dell’uomo. Cadde, non morì, da sempre mi fa risuonare nel cuore lo schianto del grande albero che, provato dagli incessanti colpi della scure, in un preciso istante non ce la fa più e cede e cade. Morire è di tutti, cadere è di chi combatte.
Gli stessi verbi, dunque, la stessa forma da sempre, nelle innumerevoli versioni greche tradotte con i ragazzi, nello studio e nelle letture personali dei grandi poeti, epici e lirici, dei grandi storici, dei grandi tragici.
Non avevo mai letto un’epigrafe greca contemporanea, tutto si fermava alla storia e quando le parole della Storia, letta e studiata, si fanno così vicine, identiche e inesorabili, non si può attraversare incolumi il giardinetto fiorito e la piazza ordinata, senza esecrare questa maledetta guerra, sempre lei, questa farsa che si ripete sempre e ovunque uguale, questo marchingegno in mano a pochi folli dagli ego troppo grandi che, sempre inutile, continua a fare cadere, combattendo, uomini innocenti, uomini che immagino in massima parte miti e tranquilli, attori di vite semplici e quiete in una fiorente città-stato greca nel V secolo a.C., in un villaggetto cipriota negli anni Settanta del secolo scorso, in una cittadina ucraina negli anni Venti di questo nuovo millennio. Perché c’è sempre qualcuno che, dimentico della comune brevità dell’esistenza umana, deve mostrare la propria possanza, qualcuno che deve vendere le sue armi, qualcuno che deve allungare le sue già strabordanti mani sulla casa, la terra, la pace di qualcun altro.
E se la terra è bella come Cipro, patria di Afrodite, la più bella fra gli dèi, il dono di piacere a tutti si unisce inevitabilmente al pericolo di essere da tutti ossessivamente desiderata…
Sistemata lì, nel Mediterraneo orientale, con la sua natura generosa e lussureggiante, agevole trampolino di lancio verso le terre più floride dell’antichità, tappa comoda e obbligata su tutte le rotte commerciali, rifugio accogliente di tanti perseguitati, asilo tollerante di tante minoranze, cosmopolita e multietnica, Cipro ha sempre giocato un ruolo da protagonista nella storia antica, medievale e moderna dei continenti prospicienti il Mare nostrum: micenei, achei, minoici, fenici, assiri, egizi, persiani, greci, romani, bizantini, arabi e poi i Crociati inglesi di Riccardo Cuor di Leone, il lungo tempo dei Lusignano francesi, le nostre Repubbliche marinare, Genova e Venezia e ancora, dal 1571 per trecento anni, il lungo dominio degli Ottomani, che allungarono sull’isola la loro potente mano, senza tuttavia occuparsene con grande attenzione: un dragomanno in ogni città importante e tanti nuovi coloni inviati a fare presenza.
L’isola da quel momento è popolata da greco-ciprioti, discendenti dalle secolari ondate migratorie dalla penisola ellenica e da turco-ciprioti, discendenti dai coloni ottomani, giunti nell’isola dopo la sconfitta di Venezia nel 1571.
Passano i secoli e prende avvio, o forse meglio, si consolida quel famoso Grande gioco, di cui già abbiamo raccontato, nel quale è impossibile non imbattersi ogni qualvolta si metta il nasino fuori casa; quel Great Game che non annoia mai, alla faccia dell’adagio bel gioco dura poco; quel gioco che da oltre duecento anni muove con sfrontatezza le sue pedine e di cui, nel capolavoro di Kipling, Mahbub spiega a Kim: «il Gioco è così vasto che non si riesce ad abbracciarne in una volta sola se non una piccolissima parte».
Nel 1869 si inaugura il Canale di Suez e l’Inghilterra drizza le orecchie: come le farebbe agio un pied à terre nei suoi lunghi tragitti da e verso l’India, ora che la rotta del Mediterraneo le si offre così comoda. Briga e forca e nel 1877, allo scoppio della guerra russo-turca pensa bene di schierarsi dalla parte turca: compenso del suo prezioso sostegno fu niente meno che Cipro: Londra ne fece prima un protettorato e poi, alla fine della Grande guerra, la annetté ufficialmente al suo impero.
Nel 1955, il movimento di indipendenza di Cipro, guidato dal gruppo paramilitare EOKA, iniziò una campagna contro il dominio britannico. L’indipendenza giunse solo nel 1960 e, nonostante una Costituzione sapiente che garantiva un buon equilibrio fra le due etnie, presto emersero tensioni fra la maggioranza greca, favorevole alla Enosis — l’unione alla Grecia -, e la minoranza turca. Già nel dicembre del 1963, un’ondata di gravi violenze interessò l’isola ma la data cruciale, presente in tutte le epigrafi è il 1974, anno in cui la giunta golpista di Atene appoggiò un colpo di stato sull’isola che mirava alla rimozione del pacifista presidente Makarios III e alla riunificazione. In virtù del Trattato di Zurigo, che riservava ai tre paesi garanti dell’indipendenza cipriota (Grecia, Turchia, Gran Bretagna) il diritto di intervento in caso di attacchi alla sua stabilità, la Turchia piombò sull’isola e, dopo aver occupato solo una striscia di territorio a nord, fino a Nicosia, nonostante la caduta della giunta golpista greca, finì con l’occupare il 36% dell’isola, dando vita alla Repubblica Turca di Cipro del Nord, a oggi ancora riconosciuta dalla sola Ankara.
La violenza degli scontri del 1974 fu inaudita: diversi musei nelle città e nei paesi più piccoli della parte greca, la raccontano a tinte fosche, piene di astio. L’operazione turca era battezzata Attila e simile a un’orda barbarica deve essere stata la forza devastatrice turca. Massacri, devastazioni, migliaia di persone uccise fra i civili e molte altre sfollate, insanabili contrasti in merito alle proprietà, che ancor oggi risultano insanabili (l’esempio del quartiere fantasma di Famagosta, Varosa, abbandonato in pochissime ore dai greco-ciprioti, fatto oggi di scheletri di case, alberghi e negozi è impressionante!). Atrocità, violazioni dei diritti umani su entrambi i fronti, massacri, fosse comuni che ancora emergono e un numero altissimo di dispersi.
E ovunque quei caduti combattendo che oggi guardano tristi e increduli i turisti, domandando loro e forse domandandosi dopo cinquant’anni se ne sia davvero valsa la pena…
Colpa turca? Colpa greca? Di entrambe certo, ma certamente grande responsabilità della reale Inghilterra che aveva fortemente, quanto intenzionalmente, alterato i pacifici rapporti tra le comunità greche e turche che da secoli coesistevano a Cipro, contribuendo intenzionalmente ad alimentare le divisioni tra le due comunità, favorendo il nazionalismo greco e quello turco.
Semplificare non si può mai e non si deve. Il Grande gioco dura da secoli e perdura: se ho pensato di raccontare questa storia è proprio per dare voce una volta ancora all’avvilimento che giace nel cuore, di fronte ai continui orrori cui siamo costretti ad assistere. Marionette che intervengono tuonando risoluzioni che non risolvono, incontri che non fanno incontrare le parti, tonnellate di parole al vento, mentre migliaia di essere umani cadono, combattendo con le armi certo ma cadono combattendo anche la fame, le malattie, la paura, la solitudine, l’abbandono, il dolore.
Verrebbe da arrendersi, ma più forte di tutto ancora è la convinzione con la quale avevo concluso il mio articolo due anni fa precisi: «siamo ben consapevoli che il Grande Gioco non finirà mai, ma con altrettanta certezza affermiamo che c’è e sempre ci sarà il Piccolo gioco quotidiano, in cui ciascuno di noi è re o regina, importante e insostituibile. È il piccolo gioco di ogni uomo, solo apparentemente insignificante e invisibile, quello che manda avanti il mondo! (…) Guardare il mondo con lucidità e consapevolezza, studiare e conoscere, accettare senza abbattersi che certe sue logiche sono brutali, certe fami insaziabili, certe menti distorte e imperscrutabili, ma vivere con la certezza assoluta che la stragrande maggioranza dell’umanità è composta da pedine instancabili del Piccolo gioco, alfieri di valori fondamentali: ognuno di noi può e deve fare la sua parte, muovendosi nella ristretta scacchiera delle sue giornate con mosse di rispetto, tolleranza, benevolenza, in ogni direzione, soprattutto in profondità».
