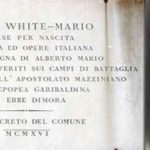
PREMESSA E JESSIE WHITE MARIO

LA PENSAZIONE
I TRADIMENTI NELLA BIBBIA

Ogni anno, nel gettare le fondamenta del nostro percorso di accademia, ritorna una scansione precisa: i grandi miti dell’Antico Vicino Oriente e dei Greci, il monoteismo, la filosofia. Ripetiamo ogni anno ai ragazzi che il fatto che la Bibbia sia un testo sacro e per molti oggetto di fede e occasione di preghiera non ci impedisce di leggerlo come un testo qualunque, che raccoglie storie e miti in un unico grande gesto narrativo. Certo, non tutto nella Bibbia è mito: esiste anche la memoria di personaggi storici mitizzata da secoli di racconto e persino la cronaca di gesti realmente accaduti; ma dipanare e distinguere queste dimensioni è spesso molto difficile e il più delle volte anche poco utile.
Sicuramente mitico è l’esordio della Bibbia, nel libro della Genesi e in particolare nei suoi primi undici capitoli, con la storia della creazione e della caduta. Non a caso vi si trova uno dei miti più ricorrenti nelle grandi storie antiche: il diluvio universale. Anche questo racconto, tuttavia, così come l’assassinio di Abele e la torre di Babele, non è che una sorta di riscrittura e di approfondimento dal grande dramma della caduta che nelle tradizioni religiose si chiama spesso «peccato originale». Ripercorrerlo significa scoprire che fin dall’inizio la finzione ha un ruolo, perché il peccato, in fondo, non è altro se non la caduta in un inganno. Il regista è il serpente, figura mitica difficilmente riducibile a un essere malvagio, più simile a un pensiero strisciante e sinuoso come un sospetto. Ma procediamo con ordine.
Nel giardino di Eden, dove l’uomo e la donna abitano insieme, c’è ogni ben di Dio (ha proprio senso dirlo). C’è anche, però, un albero che può portare la morte, un albero pericoloso. Da buon padre, Dio avverte i due: non ne mangiate, altrimenti morirete. Più che un comando, dunque, all’origine pone una parola di cura. A trasformare questo albero «della conoscenza del bene e del male» in un pretesto per la catastrofe ci pensa il serpente, la più astuta di tutte le bestie selvatiche. Si rivolge a Eva con una domanda che contiene un doppio inganno: «è vero che Dio vi ha proibito di mangiare dei frutti del giardino?». Il primo inganno Eva lo scopre subito: Dio ha parlato di un solo albero, tra i moltissimi che crescono rigogliosi. Al secondo, invece, la donna non presta attenzione: la parola di cura di trasforma in comando.
Se quanto detto non bastasse a farci capire la dinamica di tradimento, ci pensano le frasi successive: la donna «vide che l’albero era buono da mangiare». Capovolgimento singolare: come si fa a vedere un sapore? Forse la Bibbia ci sta anzitutto mettendo sull’avviso: il vero peccato abita nella finzione, nell’immaginazione.
Il cataclisma annunciato non tarda ad arrivare: l’uomo e la donna non moriranno e tuttavia perderanno la consuetudine e la fiducia trasparente con Dio e tra loro. Si accorgeranno, perciò, di essere nudi, si nasconderanno da Dio e incominceranno a volersi dominare l’un l’altro. In fondo solo i bambini gli amanti stanno nudi senza vergogna, perché negli uni e negli altri c’è assoluta fiducia. Un inganno, dunque, è l’origine del dramma della storia, del peccato e della perdita dell’innocenza.
Nel grande racconto biblico, però, ci sono anche altri inganni e non sempre sono fonte di tragedia. Anzi, in qualche modo la storia di Dio con gli uomini passerà per questi inganni e troverà del bene anche da una menzogna. È il caso della storia di Giacobbe, figlio di Isacco, figlio di Abramo e erede della promessa a lui fatta da Dio. A Giacobbe e al suo gemello Esaù è connesso uno degli inganni più astuti della storia. Quando il loro padre Isacco, ormai cieco, è vicino alla morte, decide di passare la benedizione di Dio, proprio come un’eredità, al figlio maggiore Esaù. Domanda a quest’ultimo, dunque, di andare a caccia: al ritorno lo benedirà e gusterà della sua selvaggina. Mentre Esaù esegue l’ordine del padre, Giacobbe, spinto dalla madre, si sostituisce al fratello maggiore e ruba la benedizione. L’inganno è raffinato e prevede un artificio: poiché Esaù è villoso, Giacobbe deve rivestirsi con pelo di pecora affinché il padre, a tentoni, possa cascare nella trappola.
Deplorevole l’azione di Giacobbe, ma la benedizione di Dio passerà a lui, contro ogni previsione e sarà lui a prendere il nome di Israele: forse per questo la Bibbia non si scandalizza e racconta la scena come se fosse un gioco.
Da un personaggio come Giacobbe, d’altronde, si impara ad aspettarsi di tutto. Compreso un nuovo, ultimo inganno quando ormai è lui stesso vecchio e cieco. Il figlio Giuseppe gli conduce due dei suoi figli affinché possa benedire il maggiore con la mano destra e il secondo con la sinistra. Rinnovando il gesto con cui aveva sconvolto la coindicenza pacifica tra benedizioni e primogenitura, Giacobbe incrocia le mani: con la destra benedice il secondogenito e con la sinistra il maggiore.
Insomma: nella Bibbia gli inganni non hanno solo un profilo morale, ma anche un profilo storico; attivano percorsi imprevisti e rendono la storia qualcosa di più di un semplice e rigido meccanismo.
Proviamo, dunque, a raccogliere un po’ di idee, lasciando che il mito, come sempre fa, legga anche la nostra esperienza.
Matilde afferma che non sa mentire perché “ci vuole un’arte”. Gabriel sostiene che una persona che lo conosce si accorge facilmente quando mente, perciò è più semplice ingannare chi non ci conosce. Alan e Adham, al contrario, ritengono che sia più facile mentire a chi si conosce bene, perché si prevedono già i punti deboli dell’altro. Samuele invece analizza la situazione: riesce a mentire ai genitori, con i quali parla meno e può essere schivo di fronte alle domande, mentre con gli amici trova più difficile farlo.
Beatrice osserva che la parte più difficile della bugia è mantenerla, mentre Matilde parla del senso di colpa che accompagna la menzogna.
Gabriel aggiunge che talvolta si mente per il bene dell’altro. Adham porta una prospettiva religiosa: nella sua fede mentire è peccato, ma è consentito se serve a riconciliare due persone. Beatrice piccola, da poco arrivata in Accademica, riconosce che mentire comporta sempre un rischio, ma può essere necessario correrlo, soprattutto per salvare qualcuno.
Alla riflessione su chi inganni di più, se una tecnica o una persona, Matilde risponde che una persona può ingannare meglio, perché sa ragionare e adattarsi, mentre una macchina, una volta compreso il suo funzionamento, non ci inganna più. Lorenzo sostiene che una persona può “farti ragionare come vuole lei”. Beatrice cita gli sconti e le creme di bellezza come forme di inganno quotidiano operato dal marketing. Adham osserva che chi si mostra vittima o piange può essere più manipolatore di chi si mostra forte, e anche Roberto sottolinea che spesso chi appare debole può essere in realtà molto più pericoloso del forte, nel manipolare la compassione.
Adham racconta un episodio personale: per far riappacificare le sue sorelle, aveva sostenuto che la sorella più grande avesse comprato per la più piccola un pacchetto di caramelle e che lui, ingordamente, le aveva mangiate. Inventare una gentilezza e fingere una colpa è la dimostrazione che esistono diversi modi di mentire, del tutto dipendenti dallo scopo ultimo.
Dalla riflessione emergono parole che collegano il mito biblico e la vita umana: inganno, creatività, emozione, memoria, futuro, promessa, manipolazione, parola, travestimento, estetica, pianto, vittimismo, legge.
L’inganno, dunque, non è soltanto una menzogna, ma un intreccio di linguaggio, desiderio e percezione. È una forza che attraversa la storia umana e le sue narrazioni, rivelando, più che nascondendo, la fragile complessità dell’esperienza.
