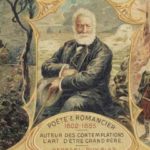
“IO SONO DI QUELLI CHE PENSANO…“
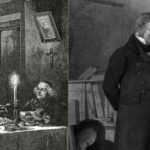
IL TRIBUNALE DELLA PROPRIA COSCIENZA
ANCHE LA GUERRA HA LE SUE LEGGI

Lunedì 28 maggio, al gruppo dei ragazzi delle Superiori (la Filoteca) è intervenuto l’ing. Giancarlo Belloni, amico da sempre della Piccioletta Barca e grande amante della storia. Ci ha raccontato di come, per quanto paradossale possa apparire, persino il caos della guerra ha avuto, nella lunga storia dell’Occidente, le sue leggi. E di come, qualche rara volta, abbiano persino funzionato…
Una definizione di legge che vi propongo è questa: l’insieme delle norme stabilite dagli uomini per la conservazione e l’ordine della convivenza. A partire da questa definizione vorrei provare a parlarvi della legge nel contesto della guerra, cioè il tentativo di mettere ordine nel caos. Vorrei farlo a partire dalla storia delle leggi. Una premessa doverosa è che vi parlerò unicamente di storia dell’Europa e in particolare dell’Italia. Di altre culture non so abbastanza per potervi dire qualcosa di sensato.
Partirò dal medioevo, però c’è un illustre precedente che racchiude in sé già molti degli aspetti che vedremo: si tratta della Tregua olimpica. I giochi olimpici antichi si tennero dal 776 al 393 d.C.; la tregua si estendeva a tutta la Grecia per chiunque partecipasse alle grandi feste e ai giochi nazionali; in teoria dovevano essere sospesi tutti i conflitti e tutti potevano attraversare territori nemici per recarsi ad Olimpia. Il punto più basso ci fu nel 364 a.C. quando si verificò uno scontro armato tra i Pisatidi (di Pisa) e gli Elei (di Elis) che si contendevano l’organizzazione dei giochi stessi, che avvenne proprio nell’area e nei giorni dei giochi.
Durante l’Impero Romano le cose furono tutto sommato semplici: la dichiarazione di guerra e l’investitura sacra del bellum conferiva il diritto del vincitore a depredare i beni del nemico (praeda bellica), a ridurre i superstiti in schiavitù e a uccidere in caso di necessità (iure caesus).
Il medioevo fu, invece, un tempo particolarmente interessante per il nostro tema. Certo, di fronte a un periodo di mille anni, si rischia sempre di parlare con poca precisione. La guerra nel medioevo era una situazione quasi permanente, fu il modo più comune per affrontare dispute tra poteri diversi. Per dare un’idea, Carlo Magno in 46 anni di regno (prima come re dei Franchi poi come re dei Longobardi e poi come imperatore dei romani) ha fatto 44 spedizioni militari. La dissoluzione del potere centrale (quello romano) alimentò conflitti sparsi, solitamente però senza odio e senza massacri, ma che implicavano comunque enormi problemi per la popolazione, sebbene per lo più in via indiretta: requisizioni, saccheggi, devastazioni, carestie, e epidemie.
La Chiesa (unica autorità in qualche modo super partes) cercò più volte di affrontare il problema. Ne nacquero alcuni movimenti, come la Tregua di Dio, la Pace di Dio, Landfrieden. Dall’XI secolo si diffusero in tutta l’Europa occidentale per sopravvivere in una qualche forma fino al XIII secolo. Di fatto si sancivano tempi (domenica, giorni di festa, periodi liturgici, ma anche giorni di fiera) e luoghi (chiese, monasteri, ospizi, mercati) e categorie di persone (chierici, pellegrini) che dovevano essere risparmiati dalla guerra. Funzionarono? Sì e no… Sappiamo che il rifugiarsi in chiesa è rimasta una soluzione per lungo tempo (come Fra Cristoforo, nei Promessi Sposi, che si rifugia in convento) ma la battaglia di Bouvines fu combattuta il 27 luglio 1214, domenica.
Nel medioevo, comunque, la guerra è fatta soprattutto dai cavalieri, signori a cavallo che si riconoscono tra loro. La necessità di arginare la violenza dei cavalieri è forse anche ciò che soggiace ad alcuni fenomeni culturali, come l’ideale del cavaliere difensore dei pauperes (non tanto i poveri quanto i disarmati), il monaco-cavaliere, il crociato (combatte nemici esterni alla cristianità). Alcune regole, invece, sorsero spontanee, per esempio il rispetto per i prigionieri (che servivano soprattutto per riscuotere un riscatto). Il rispetto viene meno, però, quando i combattenti non si riconoscono tra loro, per esempio quando cavalieri sono abbattuti da fanti. Nella battaglia di Courtrai, dell’11 luglio 1302, l’esercito del re di Francia Filippo il Bello (circa 3000 cavalieri e 4000–5000 fanti in appoggio) fu sconfitto dalle milizie comunali fiamminghe (circa 10.000 fanti), che fecero circa 1000 morti. I fanti, evidentemente, preferivano il bottino immediato al riscatto.
Tra diversi, tra persone che non si riconoscono, la guerra non ha mai regole: così avviene nelle le guerre civili (ciascuno vede nell’altro un traditore), nelle guerre ideologiche, e in particolare, nel contesto europeo, nelle le guerre di religione.
La speculazione teologica, filosofica e giuridica, portò persino alcuni autori ad affrontare apertamente il tema del diritto alla guerra (quando una guerra è giusta?) e del diritto nella guerra (come si può condurre la guerra in modo giusto?). Si posero così le basi di quello che diventerà il diritto internazionale. Alcuni esempi di testi poi diventati fondamentali: Giovanni da Legnano, De bello, de represaliis et de duello (1360); Honoré Bonet, Arbre desbatailles (1481); Francisco Suarez, Disputatio De Bello (1600 circa); Hugo de Groot (Ugo Grozio), De jure belli ac pacis (1625).
Un caso particolare è rappresentato dall’assedio. Da sempre l’assedio (di un castello, ma più spesso di una città) prevede regole precise. Quando arriva un esercito, la città può decidere di accoglierlo in amicizia, in questo caso probabilmente se la cava fornendo spontaneamente i rifornimenti, senza ulteriori danni. Ma se la città si chiude e si arriva all’assedio, la consuetudine prevede tre possibili soluzioni: gli assedianti capiscono di non farcela, desistono e se ne vanno. Quando gli assediati capiscono di non farcela e allora si contrattano i termini della resa (accordi articolati in capitoli, da qui il terminecapitolazione). Se invece resistono a oltranza, quando le difese cedono del tutto gli assedianti hanno tre giorni per fare quello che vogliono.
Dopo le guerre di religione dell’epoca moderna, si passa ad una lunga fase in cui la guerra torna ad essere una questione tra professionisti, molto formalizzata fino ad arrivare alla guerre en dentelle, la guerra con i merletti del ‘700. A partire dal XVI° secolo ma soprattutto dal XVIII°, entrano in uso i cosiddetti cartelli che si stipulano in occasione di questa o quella guerra, di questa o quella battaglia, per regolare il trattamento dei feriti o ilriscatto prigionieri, e talora anche per vietare l’impiego di certe armi. In questo periodo si cerca di non coinvolgere la popolazione civile, si organizza la logistica e la guerra assume quasi un carattere sportivo. Per esempio, si ricorda lo Scontro di Lindesnes avvenuto il 26 e 27 luglio 1714 tra una fregata danese e una fregata svedese, nell’ambito della grande guerra del nord per il controllo sul Mar Baltico. La fregata danese Løvendals Gallej (con falsa bandiera olandese) incontra la fregata De Olbing Galley che naviga con bandiera inglese perché arriva dai cantieri navali inglesi per essere consegnata alla marina svedese; la De Olbing aveva una regolare lettera di corsa che le consentiva di combattere contro i nemici danesi-norvegesi. Le fregate si avvicinano, la Løvendals issa la bandiera danese, la De Olbing quella svedese e inizia lo scontro che dura fino alla sera del 26 per riprendere poi la mattina del 27. Dopo circa quattordici ore, entrambe le navi risultano ormai gravemente danneggiate. A questo punto, il comandante della Løvendals, a corto di munizioni, si avvicina alla De Olbing e invia un messaggero con una lettera per il comandante avversario: nel testo, dopo aver ringraziato per il bel duello, si dice dispiaciuto di non poter continuare lo scontro a causa dell’esaurimento delle munizioni e, anziché arrendersi, chiede all’avversario un po’ delle sue palle di cannone, in modo da poter continuare la lotta. Non conosciamo le perdite, però capiamo molto sull’idea di guerra che avevano allora.
Tutto cambia con le guerre della Rivoluzione francese e soprattutto con Napoleone. Questa volta gli eserciti sono enormi masse di uomini: non possono più basarsi su una propria logistica e tornano a “vivere del territorio”, cioè al saccheggio.
La svolta decisiva si ha dopo la famosa battaglia di Solferino del 24 giugno 1859. Lo scontro avviene nel contesto della seconda guerra d’indipendenza italiana, tra l’esercito austriaco e quello franco-piemontese dall’altro. Alla battaglia è presente Henry Dunant, un uomo d’affari svizzero, che assister alle sofferenze dei 40.000 feriti di entrambi gli schieramenti. Dunant si mobilita per assisterli e scrive Un ricordo di Solferino (1862) che manda a tutti i sovrani d’Europa. Si arriva così, tramite suo, a istituire la Croce Rossa e, poco dopo, la Convenzione di Ginevra del 1864 (per precisione: Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei militari feriti in guerra). La Convenzione segna la nascita del diritto internazionale umanitario (DIU) o diritto bellico o diritto dei conflitti armati, che ancora oggi cerca di mettere ordine nelle complesse questioni legate alle vittime della guerra. Alla convenzione del 1864 ne sono seguite molte altre che hanno affrontato soprattutto i diritti dei non combattenti: feriti, malati, naufraghi, prigionieri, civili.
Ecco alcuni principi fondamentali:
Certo, ci si dovrebbe chiedere: chi fa rispettare queste regole? Oggi esistono alcuni strumenti: la Corte internazionale di giustizia, fondata nel 1945, emanazione dell’ONU, che derime controversie fra stati in funzione di arbitro. C’è poi la Corte Penale Internazionale, fondata nel 2002, che deve giudicare individui colpevoli di crimini internazionali: ha giurisdizione nei 125 paesi che aderiscono, ma non negli altri (tra cui USA, Israele, Turchia, Russia, Cina, Siria, Iran…); nei tempi recenti, abbiamo sentito parlare di sentenze da questa corte, perché essa, sebbene non abbia alcun potere su Russia e Israele, ha giurisdizione nei territori Palestinesi e in Ucraina. Ma la fragilità di questi strumenti è evidente: la legge può arginare il caos ancora (e sempre) solo tra esseri umani che si riconoscono reciprocamente.
