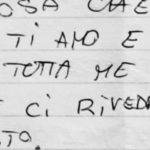
LA LETTERA PERDUTA

MILANO ILLUMINATA
QUANTO VALE UN METRO CUBO DI CONOSCENZA?

Uno spettacolo teatrale, una vacanza estiva nel bellunese, un’intera giornata di visita alla diga e ai luoghi del disastro, un lungo lavoro di preparazione. Perché ancora oggi, sessant’anni dopo, parlare così tanto del Vajont? Si chiudeva con una domanda molto simile a questa anche lo spettacolo di Marco Paolini, il 9 ottobre 2024, capofila di centinaia di altre rappresentazioni che si sono tenute in contemporanea in tutta Italia. Con la prima trasmissione televisiva, nel 1993, Paoliniha riportato all’attenzione degli italiani una storia dimenticata, oscura, di cui ai tempi molti non sapevano nulla. Ma oggi? Oggi del Vajont si sa tutto, basta fare un giro su YouTube: documentari, interviste, immagini, persino la registrazione integrale del 9 ottobre 1993. E poi libri, studi, articoli scientifici. Oggi sappiamo tutto: perché raccontare ancora la storia del Vajont? Perché l’UNESCO, nel 2008, ha deciso di definire il Vajont come caso esemplare di disastro evitabile? Perché, nel maggio 2023, ancora l’UNESCO ha inserito l’intero archivio degli atti processuali tra i documenti di valore universale che non devono essere smarriti? Perché definire quella tragedia, ancora oggi, un evento di rilevanza mondiale?
In Piccioletta Barca abbiamo un motivo grande come una casa, la nostra. Siamo convinti che ilsapere, la conoscenza, la cultura siano inseparabili dalla responsabilità che consegnano a chi sa o crede di sapere. Cerchiamo di spiegare ai nostri piccoli soci che ogni conoscenza deve trovare una destinazione: la cultura, andare bene a scuola, prendere buoni voti, non sono cose né buone, né cattive, fino a che non generano un bene o un male. Si dice spesso che i ragazzi devono essere motivati allo studio: è vero, ma, appunto, motivare è un’operazione complessa, che può diventare ambigua. Il mito moderno dell’eccellenza, per esempio, che ti spinge a essere il migliore, consegna senz’alto una motivazione, ma non necessariamente una buona motivazione. Prendere un bel dieci a scuola, imparare a recitare o a suonare uno strumento, proseguire gli studi, laurearsi, fare un lavoro importante che comporti il riconoscimento dagli altri… nulla di tutto ciò può sottrarsi a una domanda ben più importante di «perché?», ossia: «per chi?». Per chi è questa conoscenza che hai acquistato facendo fatica, per chi è questo voto, per chi è questo spettacolo e questa esperienza? Aun adolescente può anche bastare fare le cose per sé, ma se vogliamo che quell’adolescente diventi un adulto, dobbiamo dirgli che ci deve essere dell’altro.
La diga del Vajont fu senza dubbio un’opera splendida, vertiginosa: l’orgoglio di molti, dal suo creatore, l’ingegner Semenza, fino agli operai-acrobati che lavorarono sospesi nel vuoto (tutti abruzzesi: pare che fossero stati selezionati perché geneticamente privi del senso di vertigine). Un concorso di conoscenze teoriche e pratiche, un orgoglio italiano. Eppure, quando, pochi giorni prima della grande frana, il comune di Erto, dove ormai la terra tramava quotidianamente, avvertì Enel-SADE a proposito dei movimenti sismici, gli esperti, da Roma, definirono «piuttosto azzardate» le affermazioni degli abitanti: cosa potevano saperne dei montanari di sicurezza, ingegneria, geologia? Il giorno dopo la tragedia, un giornalista della Rai chiese a una donna di Longarone, distrutta dal dolore della perdita di tutti i suoi figli, come mai non se ne fossero andati prima; ella rispose soltanto: «noi pensavo che loro ne sapessero più di noi».
Insieme a molte altre cose, il Vajont fu un disastro della conoscenza, una vicenda in cui chi pretendeva di sapere umiliò le evidenze della gente comune, li mise a tacere esibendo dati (che si rivelarono poi errati o contraffatti), competenze, esperimenti. Fu un disastro della conoscenza perché gli ingegneri non seppero ascoltare i geologi, fu un disastro della conoscenza perché i decisori non seppero ascoltare gli allarmi dei pochi tecnici rimasti, in quell’ottobre, nei pressi della diga. Negli ultimi giorni, per non creare il panico, si decise di tenere nascosto ai cittadini il rischio che appariva sempre più chiaro. Nella notte del disastro si chiusero persino le strade principali della valle, ma gli abitanti non furono né sfollati, né avvertiti. Così, invece di avere qualche giorno per decidere se scappare o meno, ebbero un minuto e mezzo: il tempo che l’onda d’urto impiegò a superare la diga e rovesciarsi sul paese. Sapere o non sapere, in quel giorno, sarebbe stato letteralmente questione di vita o di morte.
«Quanto vale un metro cubo d’acqua?», ripete Marco Paolini, come un ritornello, nel suo spettacolo. «Quanto vale un metro cubo di conoscenza?», domandiamo a noi stessi e ai nostri ragazzi. Un centro di cultura come il nostro, che ha come scopo propiziare per i nostri piccoli soci l’accesso ai gradi più alti degli studi, non può non far risuonare la domanda. Perché c’è una sinistra somiglianza tra lo studente che, dopo un bel voto guarda gli altri dall’alto al basso e l’esperto che guarda con condiscendenza un montanaro ignorante. C’è una sinistra somiglianza tra l’insegnante che umilia i suoi ragazzi perché non sanno coniugare i verbi e il grande inventore che si trastulla con l’imponenza della sua opera. Se il sapere non trova una destinazione, diventa solo due cose: autocompiacimento o potere.
Nel 2023 l’epidemiologo Pious Fateh-Moghadam ha pubblicato un libro dal titolo Guerra o salulte. Dalle evidenze scientifiche alla promozione della pace (Il Pensiero Scientifico Editore, Roma). Con le competenze che ha accumulato nella sua lunga carriera di studio nell’ambito della salute pubblica, lo scienziato analizza le conseguenze dirette e indirette delle guerre sulla salute degli umani e del pianeta. Usa gli strumenti statistici che ha affinato negli anni – gli stessi che sono serviti durante la pandemia, gli stessi che, in tempo di pace, guidano le scelte dei governi – per dimostrare quanto, dal punto di vista strettamente scientifico, le guerre siano irrazionali e quanto, invece, la ricerca della pace sia la via più coerente. Oggi molti ritengono che il pacifismo sia una sorta di cieca ideologia o un’illusione: Fateh-Moghadam spiega che esiste un pacifismo assolutista, ma anche un «atteggiamento possibilista, secondo il quale è necessario procedere a una valutazione specifica prima di formulare un giudizio a favore o contro».
È un esempio interessante e coraggioso di come la conoscenza, per essere generativa, non può che essere accompagnata da un’opera politica. Non si tratta di militanza bieca, ma di un coinvolgimento reale a favore di tutti, di un sano attivismo che non smette di ritenere che il sapere abbia una destinazione precisa: «il benessere fisico, psichico e sociale delle persone, da raggiungere all’interno dei limiti della sostenibilità planetaria». Se chiediamo agli scienziati di aiutarci a decidere in tempo di pace, non possiamo farli tacere di fronte alla guerra. Se riteniamo la conoscenza capace di guidare le nostre scelte, non possiamo rinunciare a essa quando ci fa più comodo.
Se vogliamo che i nostri ragazzi studino, dobbiamo insegnare loro il coraggio di usare la conoscenza per rendere il mondo un posto migliore.
