
GIÙ LE MANI DAI BAMBINI
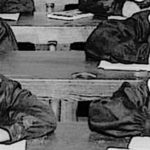
DALLA SCUOLA ELEMENTARE ALLA MEDIA: DIFFICOLTÀ E ELEMENTI DI FRIZIONE
FACCIAMO FINTA CHE…
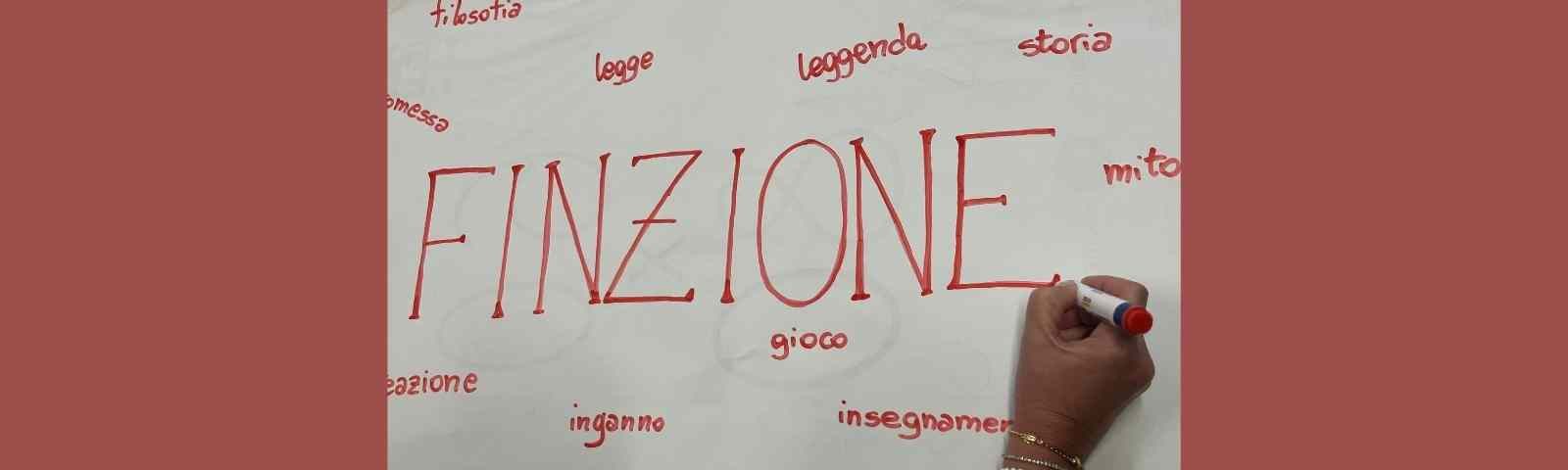
Facciamo un gioco. Ci dividiamo in tre gruppi e ciascun gruppo presenta agli altri una storia vera e una inventata, il più possibile simili l’una all’altra, così simili che risulti quasi impossibile distinguerle. E facciamo che vince chi riesce a ingannare di più.
Così incomincia l’anno accademico 2025/2026 in Piccioletta barca: con un gioco in cui si cela la parola che ci accompagnerà fino a giugno. Sono molti, in questo inizio di ottobre, i ragazzi che arrivano in Accademia: la maggior parte proviene dal Convivio ed è semplicemente scivolata da un salotto letterario per bambini a uno per ragazzi. Hanno preso il posto di chi, terminata la terza media, è a sua volta scivolato in Filoteca. Ma ci sono anche volti nuovi, giunti in Piccioletta barca per le vie più diverse, ma già, in pochi minuti, capaci di lasciarsi coinvolgere dalla suspence per il nuovo tema.
Il gioco, dunque, abbia inizio. Matilde, portavoce di un gruppo, propone due storie; la prima: «andando a trovare i nonni in Abruzzo, ho mangiato nella trattoria in cui sono stati inventati gli arrosticini»; la seconda: «una volta, in un paese del deserto, ho visitato un piccolo museo dedicato alla storia del WC». Si vota. Con un certo disappunto, scopriamo che la storia dell’invenzione degli arrosticini è destinata a rimanere oscura, ma ci consola l’idea di potere un giorno andare là dove la toilette non ha segreti: il gruppo di Matilde ha vinto. Gli altri due gruppi (uno ci ha fatto scegliere tra l’incontro con Gerry Scotti o Cannavacciuolo, l’altro tra il piazzamento nella top 20 delle olimpiadi di matematica e la visita a scuola di Roberto Bolle) si piazzano parimerito, con un certo distacco.
Cosa ha reso gli arrosticini immeritatamente più credibili dei vasi da notte? Cosa, soprattutto, ha spinto i nostri creatori di storie a scegliere proprio questi soggetti per ingannare i compagni? Adham, matricola in Accademia, risponde alla prima domandadicendo di avere colto la verità guardando l’espressione di chi parlava: piccoli dettagli, ma inconfondibili. Nicolas, invece, ha colto increspature di incoerenza nelle storie; Alan era semplicemente bene informato. Per quanto riguarda la seconda domanda, la costruzione dell’inganno ha seguito due vie differenti: la manipolazione di un evento realmente accaduto, fino a farlo diventare falso, oppure l’invenzione di un fatto palesemente fittizio, ma plasmato nella forma del verosimile.
Raccolto questo piccolo bagaglio di esperienza, non ci resta che svelare la parola dell’anno, non senza avere chiesto ai giovani accademici di azzardare qualche ipotesi. Qualcuno suggerisce “inganno”, anche se vanno per la maggiore anche “bugia”, “manipolazione” e, soprattutto “verità”; riguardo a quest’ultima, spieghiamo ai ragazzi che un tema così grande incute troppo timore persino a noi. Dopo qualche dritta, Federica e Isabel indovinano: FINZIONE è la parola e sembra da subito riscuotere un buon gradimento.
Come ogni anno partiamo dall’etimologia e ricordiamo a tutti che le parole, proprio come le persone, hanno una storia; così come per capire l’altro può essere utile conoscere la sua famiglia di origine, allo stesso modo accade per un vocabolo. Non solo: proprio come l’infanzia per le persone, l’origine remota delle parole segna in modo indelebile la storia del loro significato. Finzione deriva dal verbo latino fingo, -is, finxi, fictus, -ĕre, il cui primo significato è creare, plasmare, modellare. Il passaggio dall’opera manuale a quella immaginifica è intuitivo, ma oggi, nella parola italiana, non c’è più traccia di materia, se non in un suo aggettivo, fittile, che identifica le statuette in terracotta.
Non fatichiamo a riconoscere, tuttavia, la pertinenza dell’atto di plasmazione, se ripensiamo al gioco appena terminato: si è trattato di manipolare la realtà, proprio come se fosse argilla, fino a darle una forma diversa.
La percezione della maggior parte dei ragazzi, rispetto a questa parola, è sostanzialmente negativa: non amano che si menta loro e tantomeno che li si manipoli; non manca, però, chi la percepisca come realtà positiva, intuendone la potenzialità, soprattutto nell’universo dell’arte, della letteratura, del teatro o delle grandi storie. Hanno entrambi ragione: finzione è vox media, come sempre accade nella scelta delle nostre parole, perché non avrebbe alcun senso lavorare un anno intero su un concetto univoco e perentorio.
Come diceva il filosofo francese Bruno Latour, «la realtà, dividendoci, ci unisce».
