
IL RAGAZZO È INTELLIGENTE. PERCHÈ NON SI APPLICA?

ἜΠΕΣΕ ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ”. CADDE COMBATTENDO…
LA SCUOLA MEDIA ACCUSA. LA SCUOLA ELEMENTARE RISPONDE.
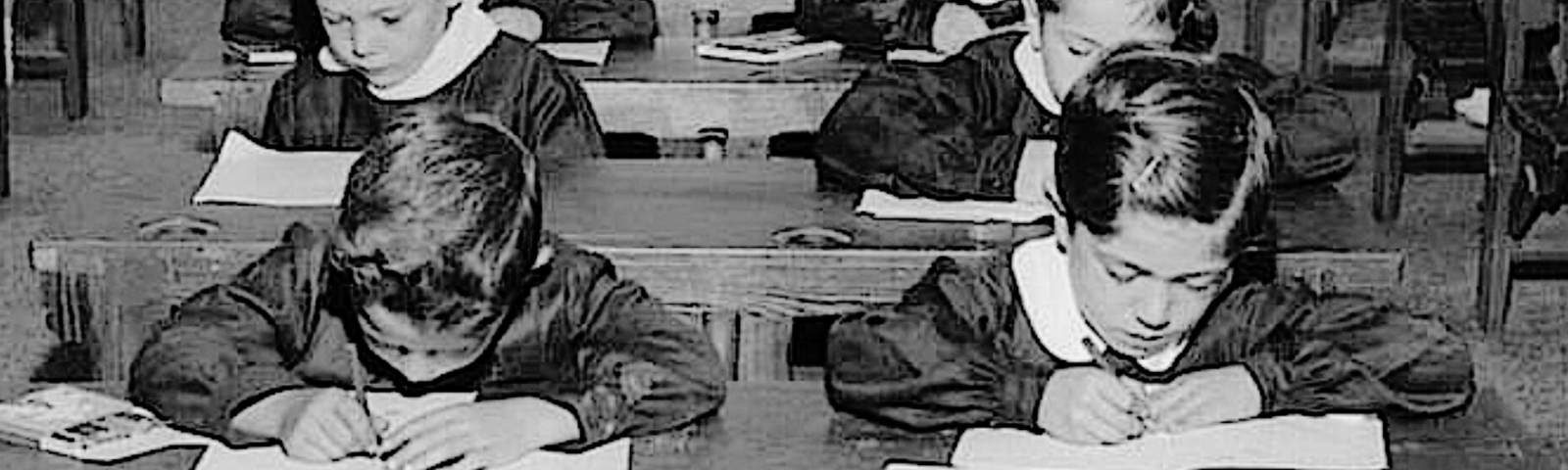
Per quanto concerne la preparazione scolastica è altrettanto difficile fare un discorso generale. Nel documento Incontro fra Presidi di scuola media e Direttori didattici del 1969 si legge: “In effetti, molti alunni si sono presentati alla scuola media con una preparazione buona, altri con una preparazione discreta o comunque ritenuta sufficiente o quasi sufficiente, altri infine con una preparazione decisamente scarsa.”
Da alcuni convegni organizzati nel 1964 dal Ministero della Pubblica Istruzione risultò, però, che gli insegnanti delle prime medie posero in rilievo i bassi livelli di preparazione riscontrati negli alunni licenziati dalla scuola elementare e soprattutto provenienti da scuole elementari delle campagne o dei rioni più popolati (i primi in genere provenienti da scuole uniche, pluriclassi; i secondi da scuole con alto indice di affollamento). Questi stessi insegnanti presentarono la richiesta di una maggiore severità nella preparazione e nell’esame di licenza elementare.
Esaminando più da vicino quali siano queste carenze nozionali, osserviamo che i professori, rifacendosi a quanto è affermato nel penultimo capoverso della premessa ai programmi della scuola primaria esprimevano le seguenti notazioni: per quanto riguarda la lingua italiana, gli alunni in genere sono dotati di un bagaglio di vocaboli molto limitato; molto spesso, in sostanza, il loro vocabolario non è superiore a quello strettamente necessario per le normali frasi della vita quotidiana. Se si allarga un po’ il discorso, allora la comprensione diventa imperfetta e nebulosa o del tutto inesistente. Anche i migliori leggono piuttosto male, talora la lettura è eseguita col dito oppure è spezzata e inceppata. L’impegno che la lettura richiede e il limitato vocabolario, inoltre, fanno perdere di vista il quadro generale di riferimento e i ragazzi non capiscono bene quello che leggono. Nessun gusto, poi, per la lettura, che è circoscritta quasi esclusivamente ai soli libri di testo.
Questa situazione negativa si riflette naturalmente sull’insegnamento di tutte le materie; non infrequenti, ad esempio, sono i casi di alunni che non sanno risolvere un problema di aritmetica soltanto perché non capiscono il testo, e il testo è stato particolarmente curato dall’insegnante perché risultasse facile e piano.
Quasi nessun alunno è totalmente immune da errori di ortografia; per la maggioranza questi sono all’ordine del giorno. Nel documento già citato si legge ancora:
L’ortografia — si rileva — è esclusivo assunto — anche giuridico — delle elementari, non impegno della media, sia perché effettivamente essa trova tempo d’oro nella scuola primaria, sia perché i programmi del 1963 non ne fanno carico alla seconda fascia dell’obbligo.
Anche la conoscenza dell’analisi grammaticale è lacunosa: molti alunni non sanno riconoscere nemmeno i sostantivi o le voci verbali; all’inizio della scuola media sarebbe sufficiente che i ragazzi sapessero riconoscere con sufficiente sicurezza, i verbi, gli aggettivi e i pronomi più usati.
Per quanto riguarda l’aritmetica si presentano notevoli lacune. Generalmente sicura è la conoscenza dell’addizione e della sottrazione, un po’ incerta quella della moltiplicazione, ancor più incerta quella della divisione, soprattutto se vi sono due o tre cifre, o poco ancora, dei decimali.
In parecchi alunni si rileva inoltre una scarsa conoscenza del sistema metrico decimale. Meno grave è il fatto che molti incontrino notevoli difficoltà nella terminologia, alla quale non sono abituati, o non conoscono ancora ben determinati concetti come quello di fattore o quello di multiplo. In fondo è necessaria solo una conoscenza sicura delle quattro operazioni e la capacità di risolvere facili problemi di aritmetica.
Circa la storia, la geografia e le scienze, i ragazzi possiedono in generale una serie di nozioni. Manca il senso dello spazio, del tempo e delle relazioni fra le cose del mondo naturale.
Sul piano comportamentale vengono spesso segnalate la “instabilità, indisciplina, scarso senso dell’ordine e del dovere”, risultato spesso volte di un’esperienza di discipline ma di tipo autoritario nella scuola elementare.
Un ultimo rilievo è presentato dal fatto che la scuola prima non disponendo ancora di sufficienti provvidenze e strutture per il recupero dei suoi disadattati, licenzia finora un notevole numero di disadattati o impreparati che si iscrivono alla scuola media.
Quel che rispondono i maestri.
Di fronte a questi rilievi i maestri fanno presenti le numerose difficoltà della situazione in cui si trovano a operare, sia a livello di struttura della scuola, sia quanto all’ambiente sociale in cui sono inseriti.
“In ordine alle critiche di base, mosse ai programmi, si obietta che questi hanno la giuridica veste imperativa di un decreto del Capo dello Stato, che tutti sono tenuti ad osservare e che quindi esse non possono direttamente i maestri ma, semmai, il legislatore”.
Tralasciamo tutta la problematica dell’adeguatezza o meno dei programmi della scuola elementare, problematica che è stata oggetto di numerosi studi e che richiederebbe una trattazione che non può essere ridotta a queste poche pagine di introduzione, e vediamo invece quali siano gli elementi di difficoltà nella conduzione della scuola elementare, nella situazione attuale.
Difficoltà che ci aiutano a capire i motivi per cui gli alunni della scuola elementare possano accedere nella media con carenze di ordine formativo o culturale, tali da far sì che quest’ultima esprima delle obiezioni sulla scuola primaria.
Sono difficoltà da ricondurre a un triplice ordine di fattori:
gli insegnanti: spesso presentano una preparazione di base incerta, una scarsa attitudine professionale e una scarsa volontà di aggiornamento. In alcuni luoghi, soprattutto in provincia, gli insegnanti mutano ogni anno, in quanto la provincia è una tappa del percorso di avvicinamento al più ambito incarico in città. Inoltre, da parte del corpo insegnante c’è un’accettazione piuttosto semplicistica dei programmi, con una lettura piuttosto facilitatrice, soprattutto per quanto concerne i contenuti alfabetici e culturali.
le strutture: le classi sono spesso eccessivamente numerose, anche se il rapporto insegnante-alunno nella media nazionale è di 21,5 ed è quindi un rapporto ottimale. Bisogna considerare però che, nella pratica reale, le cose stanno diversamente, in quanto si passa da un rapporto 1 a 5 nelle zone di campagna in via di spopolamento, a rapporti che raggiungono talora valori altissimi (60) nelle zone cittadine ad alta concentrazione.
Esiste inoltre la grave piaga della pluriclasse, ancora diffusa nella campagna e nelle zone dove le comunicazioni sono difficili a causa dell’asprezza della configurazione territoriale. Il sistema di dépistage e di recupero è assolutamente insufficiente ed è causa del permanere nella scuola di fanciulli, per i quali sarebbe necessaria una educazione speciale. Esistono inoltre notevoli difficoltà ad instaurare rapporti con le famiglie per creare un clima di collaborazione in cui possa avvenire la crescita del figlio alunno.
le situazioni socio-economiche e socioculturali: esiste una fortissima migrazione interna, che crea problemi soprattutto per la presenza dei figli di immigrati nelle scuole, nella cintura esterna delle grandi città. Ulteriori difficoltà nascono a causa dei bassi livelli socio-economici e socioculturali che incidono notevolmente sul rendimento scolastico degli alunni.
La scuola elementare a sua volta “controaccusa” la scuola media definendo alcuni docenti secondari come nostalgici della vecchia scuola media selettiva e preclusiva e dei suoi sistemi di governo didattico e disciplinare. Questa accusa è spesso ben fondata e riveste una certa importanza: infatti la riforma della scuola media ha chiamato l’insegnante a responsabilizzarsi nei confronti dei nuovi scopi, la realizzazione dei quali dipende essenzialmente dall’impegno che egli ci mette per raggiungerli.
È pertanto essenziale che il grado di adesione ai nuovi fini della scuola sia elevato proprio perché, per incontrare bilici motivazionali, egli che occupa istituzionalmente la posizione simmetrica a quella degli allievi e che interagisce più assiduamente con essi, per cui, a seconda delle sue modalità e dei contenuti di tale interazione, i fini vengono più o meno raggiunti.
Alcuni insegnanti non hanno saputo assumere il nuovo modello di scuola e si trovano quindi in una posizione di rifiuto e di resistenza. Un’indagine svolta da Vincenzo Cesareo mette in luce come il 29,6% degli insegnanti di scuola media intervistati rifiuti la riforma; le percentuali più elevate di rifiuto si riscontrano fra gli insegnanti di ruolo, soprattutto in città. Questi insegnanti, nell’esprimere il loro rifiuto, motivano la loro opposizione con dei riferimenti precisi ai principi informatori della riforma e precisamente non approvano:
l’estensione dell’obbligo scolastico sino al quattordicesimo anno di età. Il più delle volte, l’estensione dell’obbligo viene messa in relazione al verificarsi di un abbassamento del livello medio di preparazione degli allievi;
la funzione formativa della media unica. A causa di questa funzione, infatti, al cui servizio viene posto, l’insegnante ritiene che la propria posizione d’esperto in materia specifica venga trascurata; e che contemporaneamente egli sia declassato a livello di maestro elementare, di educatore generico.
la democratizzazione dei rapporti fra docente e discente. Molti professori ascrivono ad essa la loro opposizione alla scuola media, sostenendo che i ragazzi non percepiscono più l’idea di autorità;
il principio dell’individualizzazione dell’insegnamento. È rifiutato da alcuni docenti, i quali perseverano nel considerare la scuola media come luogo di formazione della futura ‘élite’ e non come luogo di formazione di tutti i ragazzi. Da questa indagine risulta che, su dieci insegnanti, tre sono ancorati a una visione anacronistica di scuola media.
