
PAROLE DALLA RESISTENZA ITALIANA
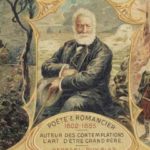
“IO SONO DI QUELLI CHE PENSANO…“
DETTATO COSTITUZIONALE E SCUOLA DELL’OBBLIGO
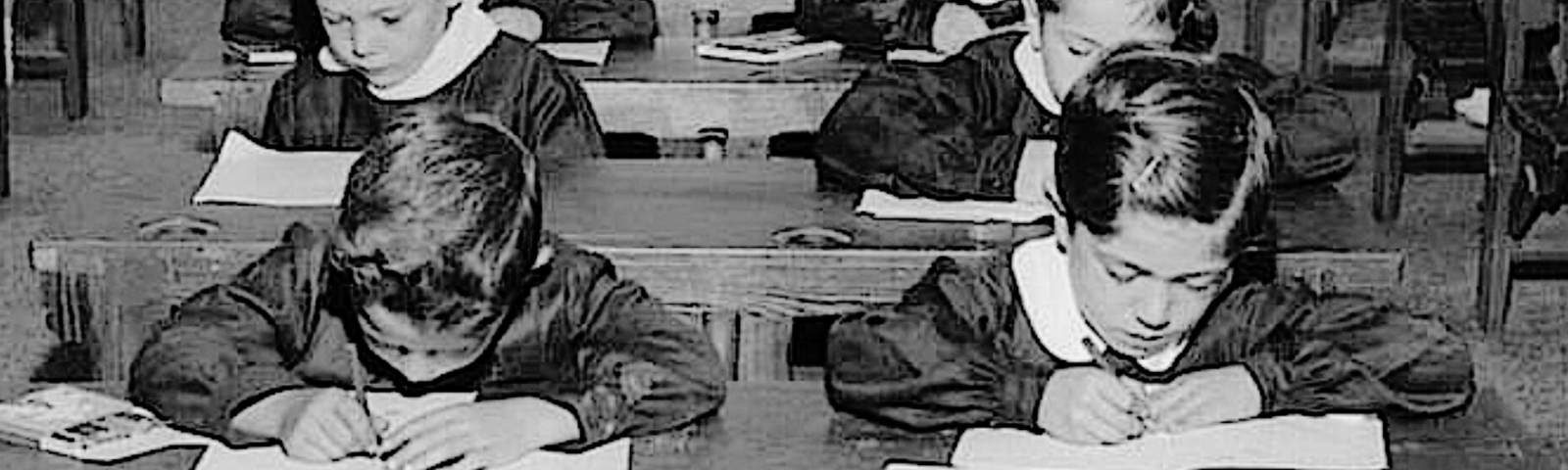
La Costituzione (art. 34) prevede una scuola di otto anni obbligatoria e gratuita per tutti i cittadini. Questa scuola ottennale si articola in due parti, scuola elementare di cinque anni, e scuola media di tre anni.
I Programmi del ’55 furono anche un tentativo, sospinto delle associazioni di categoria degli insegnanti elementari, di occupare il triennio 11–14 anni con la scuola “post-elementare”, ancora prima che questa venisse legiferata. È noto infatti che gli anni 1945–1962 hanno visto un continuo sforzo di dette associazioni per impadronirsi del triennio della preadolescenza, sforzo che ha ritardato, con grave danno, la riforma della scuola media.
La diffusa disoccupazione magistrale portava infatti quelle associazioni a sostenere che occorreva all’Italia una scuola dell’obbligo, di otto anni, da offrire a coloro (e sarebbero stati – si diceva – i più) che non avrebbero continuato gli studi (non si approfondiva perché, né si indagava abbastanza sulle deleterie conseguenze di tale mancata continuazione).
Per costoro, si sosteneva, nessun insegnante migliore dell’insegnante elementare, unico, e già esperto dei precedenti scolastici e degli ambienti di siffatti alunni.
Si riteneva che il testo dell’art. 34 della Costituzione desse un valido fondamento a tale tesi, con il suo enunciare gli otto anni di scuola dell’obbligo come se dovessero costituire una sola scuola.
In verità lo stesso concetto di “scuola dell’obbligo” era idealmente superato, sia perché non di obbligo, si deve parlare, ma di diritto allo studio; sia perché già si parla di protrarre l’obbligo fino a 19 anni; sia perché esigenza prima di una scuola – prolungata o meno – è quella di aderire allo stadio dell’età evolutiva dei rispettivi alunni, cioè – nel caso degli otto anni dell’art. 34 – ad almeno tre stadi diversi, l’ultimo dei quali, la preadolescenza, ha esigenze fortemente differenziate da quelle della fanciullezza.
L’aver voluto tentare d’impadronirsi del triennio 11–14 anni condusse i compilatori dei Programmi 1955 a diluire i precedenti programmi della Scuola primaria non più in cinque, ma in otto anni; cosicché, se un appunto va fatto ai programmi del secondo ciclo, esso non è un’accusa di troppa densità, bensì di diluizione.
Da molte parti oggi ci si domanda se gli insegnanti elementari – accada questo a causa dei programmi, o di una minore preparazione professionale, oppure a causa delle depresse condizioni socioculturali di molti ambienti sociali – facciano buon uso dei poteri mentali e delle doti affettive dei loro alunni nelle classi III, IV, V.
Il livello di preparazione, con il quale molti alunni giungono oggi alla Scuola Media (se ci arrivano), non appare certo soddisfacente.
Ciò non è dovuto ai nuovi programmi della scuola media (1963), che sono stati studiati in aderenza ai bisogni della preadolescenza, e che per di più, nella loro Premessa, prescrivono che il Consiglio di classe di ciascuna prima media accetti il livello di sviluppo, cui la scuola elementare abbia potuto far pervenire di fatto gli alunni singoli e da tale livello faccia esordire la propria azione individualizzata.
Per fortuna dell’Italia, la tesi post-elementare, avendo la legge di riforma n. 1859 optato per una scuola media a struttura assolutamente unica, è totalmente caduta e, con essa, è caduta quella parte dei programmi del 1955, che intendeva prefigurare e precostituire la post-elementare nel cosiddetto terzo ciclo.
Quindi, chi voglia oggi parlare correttamente di dettato costituzionale e risparmiarsi l’ormai superato discorso sulla scuola dell’obbligo deve guardare allo spirito generale della Costituzione, non certo orientato a favorire che gli studi dei più vengano interrotti a 14 anni. La stessa Costituzione, con l’assegnare fin dall’art.3 alla Repubblica il compito di “rimuovere gli ostacoli” che si appongono alla piena espansione di ciascuna persona, indica la più vera natura del problema da affrontare; il quale non è nemmeno di puro condizionamento sociale che include, tra i fattori condizionatori, la scuola elementare stessa, nelle sue odierne condizioni.
Perciò anche chi, come colei che qui scrive, ricerca le cause del cattivo rendimento nel secondo ciclo primario non deve lasciarsi attrarre e deviare da un pericolo di nozionismo, che non è certo da imputare ai programmi del ’55; deve, al contrario, saper considerare il problema allo studio in tutte le sue componenti, evitando di riesumare come via di soluzione la superata sirena del post-elementarismo.
Noi sappiamo bene che la scuola elementare è condizione necessaria, ma non sufficiente, per garantire al cittadino la possibilità di inserirsi coscientemente nel mondo; sappiamo anche che la stessa scuola non è sufficiente e auspichiamo lo spostamento dell’età dell’obbligo da 14 ad almeno 16 anni, tanto più che l’evoluzione dell’umanità richiede capacità sempre più mature.
“In altri tempi si imparava un mestiere, una professione che si esercitava per tutta la vita e in numerosi casi l’apprendimento consisteva nel trasmettere l’esperienza da padre a figlio… Oggi, contadini e operai, tecnici e ingegneri, lavoratori manuali e intellettuali hanno la necessità di adeguarsi costantemente a nuove situazioni e condizioni di lavoro. Quale che sia l’avvenire professionale dei bambini e degli adolescenti, si è comunque d’accordo nel riconoscere che un obbligo imperioso incombe fin d’ora sulla scuola e i suoi maestri: sviluppare al massimo la capacità a capire, ad adattarsi a problemi sempre nuovi. La questione principale non è più l’acquisizione delle conoscenze e delle capacità, ma l’apertura di spirito, l’interesse intellettuale, la capacità di osservare, di porsi quesiti, di volere e potere rispondere a essi.” ¹
¹ Dottrens R., La scuola primaria nel mondo, cit. pg.24
