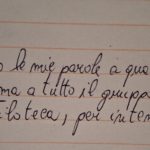
CARO AMICO, TI SCRIVO #2

LUNGHE ROTAIE DI CULTURA
«FATE CHE I LUMI ACCOMPAGNINO LA LIBERTA’»

Abbiamo concluso l’ultimo incontro celebrando il grande auspicio: massima felicità, divisa per il maggior numero: abbiamo detto che il superlativo è relativo e, accanto a massima felicità, sottintende un possibile che allontana il pensiero di Beccaria e degli Illuministi tutti dalle becere dichiarazioni populiste degli uomini forti di ieri e di oggi che gridano di essere in grado di cambiare il mondo (chissà poi se ci credono veramente…). L’Illuminismo no, non crede di detenere super poteri e restringe il suo sguardo illuminato sul migliore mondo possibile: in questo, si avvicina al Buon governo di Lorenzetti, dove poveri e cattivi continuano a esistere, ma sono oggetto di cura della comunità e della politica.
Abbiamo capito bene cosa sia una legge e cosa sia un reato: oggi parliamo della classificazione dei reati (i delitti) e, finalmente, delle pene e della giusta proporzione fra reato e pena.
I delitti si dividono in tre grandi classi, in ordine di gravità. Il delitto peggiore è quello perpetrato ai danni della società e di chi la rappresenta, poi ci sono i delitti contro la privata sicurezza del cittadino e infine quelli contro gli obblighi stabiliti dalla legge. I ragazzi sono veloci nel portare esempi: nella prima categoria, Tiziano pone l’assassinio del Presidente della Repubblica, Matilde il rapimento di uno statista (cita la vicenda di Aldo Moro), Emma la distruzione di una città o dei suoi simboli (come l’11 settembre); Mattia pensa ai brogli elettorali, così comuni ancora nelle democrazie più fragili e Nicolas alla sottrazione di denaro pubblico. Alla seconda categoria, chiaro per tutti, appartengono l’omicidio, il furto, il vilipendio di un cittadino. Più difficile è trovare esempi per la terza: Matilde pensa all’uso delle droghe, che forse rientrerebbe nella seconda categoria, benché lo spaccio e l’acquisto siano vietati dalla legge. Suggeriamo loro che il più comune di questi reati è la frode fiscale ai danni della comunità: non pagare le tasse. In realtà «ogni delitto, benché privato, offende la società, ma non ogni delitto ne tenta l’immediata distruzione» (VIII), precisa Beccaria.
Con i ragazzi notiamo che la gerarchia proposta non sempre ci trova d’accordo e, probabilmente, troverebbe d’accorto pochi cittadini contemporanei. Tiziano, per esempio, sostiene che colpire una persona è la cosa più grave di tutte e Gabriele incalza, dicendo che Palazzo Marino, per quanto bello, non vale la vita di una persona. Spieghiamo loro che alcuni attentati contro luoghi istituzionali mirano a colpire, simbolicamente, l’intera comunità. Ciò che i ragazzi dicono è vero, però dovremmo essere più scaltri: i delitti di cui maggiormente si parla, quelli su cui si scatenano giornali, televisioni e social sono quelli privati, talvolta con una curiosità che ha del morboso: il racconto di delitti familiari e passionali di cui veniamo a conoscere ogni minimo particolare ci distoglie dall’universale che tutti li sottende. Così, molti cittadini vivono immersi nella cronaca nera e ignorano i grandi movimenti e i grandi temi della giustizia.
Beccaria prosegue illustrando razionalmente il fine delle pene che è: «non tormentare un essere sensibile, né disfare un delitto già commesso; non è altro che impedire al reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e rimuovere gli altri dal farne uguali» (XII). Anche in questo caso, c’è un po’ di delusione: Matilde sostiene che la pena dovrebbe portare un po’ di pace alla vittima. Beccaria certo non lo nega, ma la sua intenzione di costruire una giustizia razionale e universale fa della pena un atto esemplare: significa che la pace per le vittime dovrà essere cercata in un altro modo, come hanno intuito in tempi più recenti quei giuristi e politici che hanno introdotto i percorsi di giustizia riparativa.
Affinché una pena sia efficace, Beccaria ritiene che debba essere «pronta», ossia il più possibile vicina al delitto commesso, così che il reo possa realmente sentire le conseguenze del male. Tutti i ragazzi, ovviamente, pensano alla lentezza della giustizia, soprattutto nel nostro Paese. Ci sono situazioni in cui i presunti criminali passano anni in carcere, in attesa di giustizia. Spieghiamo ai ragazzi che il carcere più famoso di Milano, San Vittore, è un carcere circondariale, ossia un luogo dove la maggior parte dei detenuti è ancora in attesa di giudizio. Il tempo che scorre non solo rovina l’esistenza di molti, ma trasforma il male commesso in male subito, mandando a monte l’intero sistema dei delitti e delle pene.
Beccaria si scaglia anche contro la tortura, uno strumento che oggi, nella maggior parte delle democrazie, non esiste più, ma che ritorna talvolta nella violenza delle forze dell’ordine, nel rigore eccesivo della detenzione e in tutte quelle situazioni in cui il diritto viene sospeso (come è successo, notoriamente, negli USA dopo l’attentato alle Torri Gemelle). Samuele ricorda i processi alle streghe e l’Inquisizione; riflettiamo, però, soprattutto, sul fatto che di solito la tortura serviva a estorcere informazioni o una confessione, sostituendosi così alla giustizia: concordiamo con Beccaria sul fatto che l’ultimo modo per conoscere la verità è infliggere dolore, perché la vittima dirà senz’altro quello che il giudice vuole sentirsi dire. Inoltre, aggiunge il filosofo, «l’esito della tortura è un affare di temperamento e di calcolo, che varia in ciascun uomo in proporzione della sua robustezza e della sua sensibilità; tanto che con questo metodo, un matematico scioglierebbe meglio che un giudice questo problema: data la forza dei muscoli e la sensibilità delle fibre d’un innocente, trovare il grado di dolore che lo farà confessare».
Il dolore è commisurato alla diversa percezione di ciascuno, quindi la tortura non ha alcuna base razionale o scientifica.
Più che la paura della sofferenza, la pena è efficace quando dà ai colpevoli la certezza della sua applicazione. Il timore di un castigo terribile, unito alla speranza dell’impunità, non è paragonabile alla certezza di un castigo, benché più piccolo. Di questo, i ragazzi parlano molto: gli adulti sono maestri nel minacciare punizioni severissime, così severe che non si possono nemmeno realizzare (se fai questo, non ti do più da mangiare! o il classicissimo: ti tolgo il telefono per un mese, salvo poi tremare di angoscia, se il ragazzino non è raggiungibile h 24, cosa che implica l’immediata restituzione del mezzo). Gli esempi sui genitori si moltiplicano, ma anche a scuola capita che un professore prometta conseguenze così devastanti da essere impraticabili. Quando questo accade, il meccanismo della pena si inceppa e lede l’autorevolezza di chi la invoca. Ma non è affatto tutta colpa dei ragazzi: una pena certa li renderebbe più consapevoli. In Piccioletta barca, in fondo, abbiamo pochissime punizioni simboliche, ma i nostri piccoli soci sanno che, quando è necessario, giungono inesorabili.
La riflessione di Beccaria sulla pena di morte è uno dei guadagni più importanti dell’opera. Per la prima volta questa barbara pena fu eliminata nel 1786 in Toscana, mentre l’Italia accolse la sua abolizione nel 1889; reintegrata durante il fascismo, solo nella Costituzione del 1948 fu dichiarata la sua ripulsa solenne, insieme all’affermazione del rispetto della dignità umana nell’applicazione delle altre pene, finalizzate al recupero sociale dei condannati. Il ruolo di Beccaria e di altri intellettuali, in questo, fu fondamentale. Poiché la legge lavora su quel deposito di libertà che ogni cittadino ha consegnato allo Stato e poiché nessuno mai consegnerà ad altri il diritto di ucciderlo, nella teoria giuridica di Beccaria non c’è alcuno spazio per la pena di morte, che altro non è se non un nuovo omicidio. Su questo, per fortuna, tutti i ragazzi concordano.
Dei delitti e delle pene si conclude, come giusto che sia, sottolineando l’importanza della prevenzione del reato che è il fine principale di ogni legislazione. In particolare, chiude sul tema dell’educazione.
«Volete prevenire i delitti? Fate che i lumi accompagnino la libertà! […] Un ardito impostore ha le adorazioni di un popolo ignorante e le fischiate di uno illuminato. […] L’uomo illuminato è il dono più prezioso è il dono più prezioso che faccia alla nazione e a se stesso il sovrano».
La cultura, il pensiero critico e la conoscenza della Storia non possono essere generati dalla legge, ma sono il presupposto grazie al quale i ragazzi diventano cittadini consapevoli e sani: in questo, la Piccioletta barca, è del tutto illuminista!
